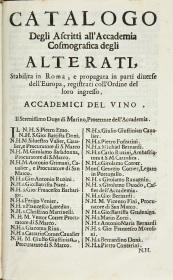di Giampiero Pulcini
Le mani nelle tasche del montgomery blu. Non fa freddo ma è un posto in cui tenerle, un modo per velare l’imbarazzo di essere solo, un po’ come fanno i bambini quando per nascondersi si coprono il viso.
Appena sera. Scivolo verso la parte bassa della città, contromano rispetto a quelli degli spritz e apericena ancora alle dieci, dei “ciao caro tutto bene” che non ammettono repliche. Lanciato in osteria: ogni sabato, nell’ora mobile in cui il pomeriggio può dirsi finito, sbircio tra le pieghe della tenda bianca sul portoncino in vetro e legno verde. Basta la presenza di un paio di beoni affinché, tirato un sospiro di incoraggiamento, mi persuada a entrare. Poggio il gomito al bancone con una vana aria di attesa, il bluff di una disinvoltura che non c’è.
“Bollicina?”
Mi piace di alcuni spumanti lo sfarzo patinato da Natale televisivo, è sufficiente un goccio per sentirmi incluso.
La sala è un corridoio coi muri coperti da doghe in rovere scuro, lo stesso delle mensole dove bottiglie toscane e francesi esibiscono lussuose etichette. Si oppongono due larghi specchi bordati di ottone; fanno sembrare più grande l’ambiente e consentono di osservare qualcuno senza guardare nella sua direzione.
Un altro specchio sta nel bagno unisex, incerto verticale, appeso dietro il coperchio del water. Mi ci imbuco a pisciare, incerto verticale pur’io, mirando l’uccello con espressione da satiro. Ne esco ringalluzzito, stringo il culo tra le sedie e caracollo al centro della stanza, incerta orizzontale tipo camera da letto di Van Gogh. Sorvolo una lapide in marmo incorniciata nel pavimento.
Qui giacciono:
la tristezza
i vini cattivi
le serate normali
i discorsi seri
le donne timorate
i calzini corti
i poveri di spirito
il riso in bianco
e tutti quelli che dicono
“lei non sa chi sono io”
Quando la sbronza orna di fantasia le maglie del visibile, l’altrui sedersi-consumare-alzarsi-salutare mi fa sentire a bordo di un piccolo Orient Express.
***
Sono Enea. Ho trent’anni: quelli che mi davano a venti, quelli che mi daranno a quaranta. Nato il 29 Febbraio, considero il mio compleanno una bugia.
Né magro né grasso, né alto né basso. Lo sguardo accigliato agganciato a terra, le spalle raccolte in avanti: la camminata battagliera è una corazza che blinda la timidezza, mi fa sembrare più cupo di quanto vorrei inibendo spesso negli altri lo slancio di una battuta o di un saluto. Autodidatta di me stesso, improvviso senza modelli; credo che il realizzarsi propinato dalla televisione – un bell’aspetto, un bel salotto, una bella fidanzata – equivalga ai tachimetri delle utilitarie che arrivano a 240 km/h ma è tanto se a tavoletta viaggi alla metà.
Rifilo polizze assicurative senza entusiasmi, bisognoso più di soldi che di un impiego. Non è vero che pecunia non olet: riscuotendo i premi a domicilio ho imparato che le banconote prese dal benzinaio odorano di gasolio, dal macellaio di sangue, dal barista di fernet, dalla parrucchiera di lacca, dalla casalinga di ragù, dal pasticcere – le mie preferite – di zucchero vanigliato.
Divido le giornate in ore diseguali, misurate da una cognizione degli eventi più umorale che cronometrica. Certe librerie, in particolare, mi scaraventano fuori da ogni concetto di puntualità. Annusare copertine, fidarsi di un incipit e presentarsi in cassa sono le fasi di una cerimonia che esalta lo stacco tra tempo percepito e quello trascorso. Un libro nuovo è sale sulla lingua e pila sul comodino; lo inaugurerò a caso, chissà quando, eccitato dalla scoperta postuma di possederlo.
Incastrata in un vicolo del centro storico, una minuscola libreria mi attrae come un magnete. Il disordine interno asseconda consultazioni rilassate, senza obiettivi. Gli anziani proprietari – marito e moglie – sono magri, loquaci, di sbadata eleganza. Affacciandomi all’unica vetrina li vedo pranzare con un frutto mentre sistemano volumi, oppure ne origlio le conversazioni svolte davanti a un tè versato dal thermos nei bicchieri di plastica.
Un soppalco in noce massello sopra l’ingresso, di dimensioni lillipuziane, è collegato a terra da una scala a chiocciola che i due ottuagenari percorrono svelti come scoiattoli; ospita un tavolino in ferro battuto, una poltrona in velluto porpora e una lampada a piantana in stile art nouveau.
“Salga, è lì apposta, serve a non fare nulla. Come la letteratura.”
Flora – la libraia – ha lineamenti affilati, abiti giovanili, pare in confidenza con la vita.
“Quando dico ‘non fare nulla’ intendo nulla-nulla. Ci vuole un posto dedicato. L’ufficio, il supermercato, la palestra sono spazi destinati a fare qualcosa. Non può mettersi in disparte a fissare il vuoto, la noterebbero. In stazione e dal medico ci sono i divanetti ma è un sostare proteso, impaziente. In casa, poi, sbuca sempre un accidente da pulire o aggiustare. Per non far nulla è necessaria un’enclave.”
Gesticola da un podio immaginario.
“Per ribellione alla frenesia abbiamo pensato al soppalco. Siamo qui da cinquant’anni e dopo venti abbiamo avvertito l’esigenza di guardarci dall’alto, forse una compensazione inconscia rispetto al vincolo di non poterci allargare. C’è questa forma triangolare, a spicchio, nell’angolo acuto pare di essere inghiottiti dai libri: certe mattine, entrando, sono sfiorata dalla claustrofobia ma basta un lettore interessato a un consiglio e il bugigattolo diventa un altopiano.”
Ispirazione in controsterzo.
“Attribuiamo agli orologi un potere che non dovrebbero avere, meccanizzano il tempo, ne dissolvono il senso dentro un’astrazione. Invece è concreto, il tempo. Sul soppalco, immobile, ho la sensazione di tenerlo addosso come uno scialle.”
Il vapore del suo monologo si condensa in polaroid color seppia. L’Oste della Mal’ora – il mio soppalco rasoterra – dista dieci minuti di cammino. Partirei subito ma servono pagine da sfogliare che facciano da tramezzo a certe occhiate indiscrete.

“Cosa compro?”
“Cosa cerca?”
“Capisco cosa che cerco dopo averlo trovato, normalmente.”
“Conosce Konrad Lorenz?”
“No.”
“L’Anello di Re Salomone. Ecco qua. Apre mondi, non gli faccia prendere polvere. Lo sgualcisca, lo sottolinei, lo usi!”
L’acciottolato replica a chiazze il bagliore dei lampioni, gli scarponcini scartano in slalom stronzi di cane e pozzanghere nere pizzicate dalla pioggia. Fungheggiano in testa fesserie che non sciolgono il grumo di tristezza schiacciato sul petto.
***
Sul fondo di un cul-de-sac brilla tremula la luce dell’osteria. Fronteggia un forno aperto di notte, coi panettieri infarinati della rassegnazione di chi è abituato a lavorare mentre gli altri riposano. Venti metri oltre fa capolino una chiesa grande quanto un garage. Quattro panche, l’altare spoglio, un fresco che nei pomeriggi d’estate invita a non tener conto dell’incapacità di pregare.
Iperbolico dire cucina. Un ripostiglio, tutt’al più, filtrato da ante sbatacchianti da saloon. Inventario: un piano in inox, un forno a microonde, un’affettatrice anni ’60 allegoria di una Lambretta – biancorossa, lucida, bombatella – e lame d’ogni foggia. Sputa umori da cambusa: spezie, acciughe, formaggi forti; il colpo di naso del locale, il suo fiato. Ci imprecano a turno Renzo, l’oste, e la factotum, Urszula, una polacca di mezz’età con le ossa tozze e iridi smeraldine montate su una faccia da poker.
In diversi asciugano bottiglie di nebbiolo prima che l’anfitrione, avvolto da un grembiule in pelle, recapiti il solito tagliere di “fai tu”. Uno in particolare ha occhi tristi, barba di settimane e ventre gonfio. Si chiama Gustavo ma a causa delle passioni per il tango e per i viaggi a bordo di un Volkswagen Westfalia bicolore è per tutti Astor Piazzòla. Indossa camice di sartoria coi colli logori, orologi di un’altra epoca e mocassini sfondati rabberciati col nastro adesivo.
Aleggia l’ombra di una resa, una stanchezza da fante in trincea, doveva esser stato bello da giovane. Declama componimenti senza capo né coda estratti da un Moleskine rosso. Una claque di una decina di persone colma con brusii di approvazione i vuoti delle studiate pause; immancabile ai rendez-vous, un’universitaria rossa di capelli e quarta di reggiseno non ha impiegato molto per congedarsi sottobraccio al poeta. La concomitanza tra avvio della frequentazione e impennata della produzione lirica le è valsa tra la marmaglia il titolo di musa aspiratrice. Gustavo minimizza. “Per carità, chi reggerebbe, la invitassi a casa mia rischierei una denuncia per modestie sessuali…”
***
Il tight con la camelia rosa all’occhiello, la cravatta allentata, l’aria sgomenta da fuggiasco.

“Loris, e te?”
“Una grappa per favore.”
“Barricata?”
“…”
“Insomma?”
“La merda a girocollo.”
“Perché?”
“Mi sono sposato sei ore fa.”
“Te l’avrà mica ordinato il dottore…”
“Me lo ha chiesto lei la scorsa estate.”
“Lei chi?”
“Lei mia moglie, da oggi. Eravamo a Parigi e io ero ubriaco.”
“Embé?”
“Ho detto va bene ma per dire, pareva talmente assurdo che non mi sono preoccupato.”
“E poi?”
“Le famiglie contente, il friccico per la messinscena. Divertente finché non ci hanno chiesto il nome.”
“Il nome?”
“Il nome se maschio o femmina.”
“Eravate incinti?”
“No, s’è dato per scontato che lo saremmo diventati.”
Renzo posa le mani sui fianchi e sorride. Gode del riverbero delle anime sbeccate quando, a mollo negli spiriti, si fanno spavalde nell’affrontare l’insensatezza della realtà. La voce profonda custodisce un’intonazione di gentilezza, invoglia a fidarsi di lui.
***
“Aspetta l’oca Martina?”
“Chi?”
Il volto è familiare ma incrociarlo fuori dal contesto abituale ne rallenta la messa a fuoco.
“L’oca Martina del libro di Lorenz che le ho dato qualche giorno fa.”
“Non l’ho neanche aperto…”
Flora saluta Gustavo, toccato da un lieve imbarazzo. “Ciao mamma”. Gli siede accanto perché altri posti liberi non ce ne sono; ordinate una zuppa di cipolle e una coppa di Chablis torna su di me.
“Resta in piedi?”
“Faccio vita sedentaria, provo a compensare.”
Accarezza il calice col rabbocco di Marsala offerto dall’oste. Osserva il figlio stuzzicare una bendisposta compagna di ballo.
“E il marito?”
“Renzo, mi ha mai incontrata con Ugo fuori dal negozio?”
“No…”
“Ci siamo scoperti estranei quasi subito. Portava Gustavo, da piccolo, ai vernissage di pittrici emergenti o ai concerti di arpiste dalle dita affusolatissime ma non l’ha mai spinto su un’altalena. Io invece ho delegato la parola ai libri, sicura che attraverso quelli si sarebbe educato alla vita. Non ha avuto fratelli né sorelle, non è stato bambino e non è divenuto adulto. Fa il medico controvoglia, si sfoga buttando giù versi da Califano di provincia tra una visita e l’altra. Ha scialacquato un patrimonio perso dietro mille sirene, l’impegno di una relazione non se l’è mai preso. Chissà qual è stato il suo imprinting…”
“A volte si diventa quel che ci anticipa, Flora.”
***
“Loris, ma gli invitati?”
“Al relais, si divertono.”
“E la sposa?”
“Con loro. Bianca laccata che pare una caldaia. Non s’è neanche resa conto della mia evasione. I salamelecchi, la spunta della lista di nozze…”
“E’ fatta.”
“Mi ha impedito di andare a Budapest con gli amici per l’addio al celibato, allora sai come ho risolto? Weekend a Venezia con la mia ex, spacciandolo per corso di formazione. Siamo stati insieme pure stamattina. Che se devo fare un figlio, lo faccio con lei.”
“Lei chi?”
“Lei l’ex!.”
“S’è mai affacciata qui?”
“Lo escludo.”
“Che lavoro fa?”
“La mignotta.”
“La che?!”
La botta di singhiozzo fa rinculare la grappa fino alla radice nasale.
“Non in strada, a casa sua. Imprenditori, professionisti, un paio di preti… uno dev’essere più che prete, con l’anello che porta.”
“Ma ci scopa!”
“Mica è la regola. Alcuni vogliono solo sfogarsi.”
“Davvero vuoi lasciare tua moglie per una che batte?”
“Uno dei pochi lavori utili in circolazione. Cura il lato B delle persone, come te.”
Renzo esita sul crinale che separa il riflettere dal mandarlo affanculo.
“Stare con una così non è diverso che accompagnarsi a un’insegnante o a un’impiegata di banca, che magari si accorgono di te quando servi e per il resto gestiscono soltanto i cazzi loro. Sostituisci la fica alla premura e siamo pari.”
“Uguale.”
“Sai quante principesse vanno con più uomini, ricambiate in cene e vestitini, e quanti cornuti fanno gli gnorri perché non hanno le palle per strappare la catenella della zona di confort?”
Voltato di spalle mastico un vino nero, dolciastro, di quelli che ogni due sorsi ne paiono cinque. Mi frigge il cervello. Ripercorro le mie poche storie melense e inconcludenti. Mi ci sono aggrappato come quegli anziani che si affezionano all’appartamentino di sempre, inceneriti dall’inerzia di giorni-fotocopia: credono d’averci vissuto e invece ci sono solo invecchiati. Provo ammirazione per lo sposo fedifrago, per quel tentativo scriteriato di salvarsi. Tolte le incrostazioni della morale comune, luccica una rivolta al conformismo che lo conserverà integro alla resa dei conti. In colpa ma non colpevole.
“Rientro alla festa, non dovessero recuperarmi per la torta sarei tenuto a scusarmi.”
“Incamminati. E sorridi nelle foto, non vorrei che lei mangiasse la foglia…”
“Lei chi?”
***

Gustavo l’incompreso. Agìto dalla quinta genziana che l’ha sgretolato come un frollino, scarabocchia sulla tovaglietta in carta paglia un fiasco che sorge dal mare. Nel fiondarsi alla toilette per far detonare una cacata pirotecnica, urta l’agenda facendola cadere in terra. Sbuca un foglio scritto in bella calligrafia; lo raccolgo, riavvolgo il nastro onirico di un epitaffio.
Un uomo sulla spiaggia, l’aurora nascosta da un temporale lontano. Cinquant’anni, le mani coperte di sangue non suo. Scrive canzoni per far volare i sassi che ha dentro trasformandoli in intrecci di note e parole. Le lascia fermentare nell’oblio, quando le canta non gli piacciono mai. Vorrebbe vedersi tornare dal mare ma non c’è che la sua sagoma di schiena seduta su una barca che punta verso il largo. La luce accenna forme di persone che conosce, l’aria elettrica fodera rimpianti scossi da un boato. L’uomo stringe i pugni e guarda il mare.
Sale le rampe di corsa. Ultimo piano, attacca la scala alla botola di accesso al tetto. Avvicina il bordo privo di ringhiera; si sporge, si blocca, torna nel monolocale. Un coltello sul tavolo, lascia lì, per ferirsi basta ricordare. Apre il frigo; intonacato da un pallore artificiale fissa il cibo e inizia a piangere.
“Non cercarmi più, sono guarito.”
“Quando sarà finita tra noi, ci sentiremo almeno a Natale per gli auguri?”
Un coetaneo bellissimo gli poggia il capo sul petto, in treno. I viadotti bucano montagne e quella domanda buca lui, chiuso in un mutismo stizzito. Conficca presagi sulla carne come frecce sul bersaglio di un amore eversivo, risolutivo.
Nell’auto appartata, di domenica mattina, due uomini si stanno baciando con ardore. Li nota per caso, pensa che quell’impeto possa competere soltanto agli amanti. E’ l’inclinazione del collo di quello biondo a colpirlo: troppa passione. “Non dureranno”, sentenzia.
Un lago al tramonto. La superficie restituisce i suoi vent’anni, quando aveva le mani immacolate e per questo lo chiamavano ragazzo. La pelle aderente alla mandibola e agli zigomi, l’espressione accesa di desiderio. Non immagina quanto sentimento sprecherà. Così si volta, apre i pugni e con una musica a tracolla s’incammina.
***
Scapicollatomi durante un panoramico giro di Pernod, raggiungo la macchina incurante del temporale. Butto la valigìna da piazzista nel bagagliaio, succhio una pastiglia al mentolo e giro la chiave terrorizzato: mi fermassero per un controllo, lo stato d’ebbrezza me lo misurerebbero a occhio nudo.
luci accese / cintura messa / benzina fatta / giro a destra freccia a destra / giro a sinistra freccia a sinistra / inspirare / espirare / inspirare / espirare
Alla quarta ripetizione del mantra, percorsi cinquecento metri a passo d’uomo, una volante dei Carabinieri m’invita ad accostare.
“Buonaseeera…”
“Salve. Patente e libretto.”
“A lei.”
“Anto’, verifica i documenti, mo’ co’ questo ci parlo io.”
Sublimo il principio d’infarto in una calma metafisica.
“Teme di decollare?”
“In che senso?”
“Nel senso se teme di decollare.”
“Scusi maresciallo…”
“Brigadiere.”
“Infatti. Dunque brigadiere…”
“Scenda.”
“…”
“Dove cazzo vai col portabagagli spalancato?! Serve l’alettone a venti all’ora?”
La Toyota Yaris ritaglia il buio trafitto dai lampeggianti blu. Il portellone lasciato aperto, rialzato a quarantacinque gradi rispetto al tetto, ne stilizza i contorni alla stregua di un avveniristico cavallo alato. Innervosito da una comunicazione radio, l’appuntato mormora qualcosa di simile a “suicidato” costringendo il superiore a interrompere il liscebusso.
“Residenza?”
“Via Gramsci, qui dietro.”
“Guaglio’, accendi un cero a uno messo peggio di te. Pigliati un’aspirina e ficcati a letto, domani tornerai non dico bello ma almeno smetterai di fare schifo.”
“Grazie, grazie colonnello.”
“Bri-ga-die-re!”
***
Galvanizzato dallo scampato pericolo, ruzzolo nel bar sotto casa. Non è un circolo di gentiluomini ma resta economico e permette di scegliere se finirsi con un cocktail o con un cornetto decongelato. Incanalato dal gestore sulla prima opzione – “meno margarina, più Margarita” – m’acculo sullo sgabello. “Sì ma fammi un Martini.”
Pesca il gin dal ripiano sopra la Cimbali e appronta la miscela con rapida cura. La trasparenza della coppetta a Y si sovrappone a quella del liquido, nessun profumo veste l’acroma durezza dell’alcol.
“Conoscevi il doc?”
“Il doc chi?”
“Trasandato, buongustaio. E mezzo frocio, si mormora.”
“Gustavo, sicuro, l’incontro spesso in osteria…”
“S’è sparato.”
“Quando?!”
“Roba di ora, non si sarà nemmeno freddato. Un amico ha sentito il botto e ha chiamato i soccorsi. Morto all’istante. Meglio. Alcuni non pigliano bene la mira, rantolano come bestie, un macello.”
“Impossibile…”
“Veniva qui per la ninna nanna: latte bollente, miele e Varnelli secco. Un bravo cristo, stranito dalla depressione. Faceva il piacione ma era pieno di buffi, qualcuno gli avrà messo pressione e s’è comprato il ferro.”
Nessi causa-effetto obliterati dal menefreghismo, incuranti dei chiaroscuri che di Gustavo erano essenza. Com’è limpida, a volte, la decisione di andarsene.
***
La bocca avvampata di Marlboro, il fischio alle orecchie frantumato dalle chiavi gettate su un vassoio d’acciaio. Strozzata la tentazione di un raptus bulimico, mi lascio cadere sul divano. Renzo, Loris, Flora, Gustavo: presenze vere o fantasticate? Mescolandole al buio prendono le sembianze di premonizioni.
Sotto il callo di un’esistenza monocroma so di non essere uno. Non lo sarò mai. Sarò il mosaico di memorie altrui seminate nel tempo; frizioni di schegge ruvide e lisce, detriti di frane interiori. Guazzabuglio mosso dagli inciampi, dal caso, ciò che ho un ambiguo piacere di essere: stabilmente in bilico.
Precipito in un sonno tombale spezzato dal gracchio del campanello. Il cellulare segna le cinque e venti; lo spioncino tace ma un fremito in dissolvenza evoca fantasmi accorsi a stanarmi. Evaporata la quiete, barcollo sino ai fornelli. La caffettiera scatarra sulla fiamma alta, l’alba sbozza il profilo dei monti di fuori. Strattonato da una solitudine tanto potente non posso far altro che uscire.
Le mani nelle tasche del montgomery blu. Non fa freddo ma è un modo per avanzare compatto, senza meta, come fanno gli adulti quando viene paura di vivere e allora si chiudono e fuggono.