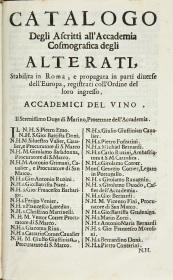di Fabio Rizzari
Fu vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza. Passata oltre una trentina d’anni dal cosiddetto Rinascimento del vino italiano, i posteri ora ci sono. Nella doppia veste di postero e di testimone diretto dei fatti, qualcosa da scrivere in materia ce l’ho.
La narrazione consolidata dei fasti rinascimentali è più o meno questa:
a) nel secondo dopoguerra si assiste a un progressivo abbandono e spopolamento delle campagne in favore dei sempre più elefantiaci agglomerati urbani
b) la politica vitivinicola delle autorità italiche del tempo decide di puntare tutto sulla produzione di grandi quantità di uva e di vino, “lasciando ai francesi la nicchia del vino di qualità”
c) come conseguenza, negli anni Sessanta e Settanta si fa vino sempre più scadente
d) ma ecco apparire, nel generale disastro e disarmo del vino d’autore o comunque del buon vino, un manipolo di visionari coraggiosi, che con sprezzo del pericolo (economico) decide – grosso modo verso i primi anni Ottanta del secolo scorso – di fare “grandi bottiglie”, per contrastare l’egemonia gallica e dimostrare che anche da noi si possono fare vini di caratura internazionale
e) con la nascita dei primi cosiddetti Supertuscan (Tignanello, Sassicaia, Solaia e soci) l’Italia mostra fieramente al mondo ciò di cui è capace
f) nei due decenni successivi fiorisce così la produzione di vini moderni, “non più scarni, immaturi e aciduli” ma “pieni, maturi, rotondi”. I bianchi non sono più liquidi incolori, inodori e insapori, ma acquistano corpo e ricchezza aromatica. I rossi non sono più liquidi diafani, aspri, vuoti, ma acquistano corpo e ricchezza aromatica.
Credo sia tempo di sottoporre a una revisione critica questa narrazione, che del resto da tempo non convince gli osservatori meno allineati. Per cominciare, essendo consapevoli dei limiti, delle approssimazioni, delle scelte avventate che hanno costruito il ponte di legno provvisorio di collegamento con la modernità. Ponte di legno divenuto nel giro di pochi anni una poco elastica struttura in cemento. Vediamoli, in un riassunto per sommi capi.
Per ottenere “vini moderni” si importano acriticamente tecniche di allevamento da zone molto più nordiche: le famose basse rese da fitti sesti d’impianto, id est ottomila/diecimila piante per ettaro. Che ci si trovi in Umbria, o in Trentino, o in Sicilia, poco importa. Che si tratti di una vigna pianeggiante, di collina, in quota o al livello del mare, poco importa. Che il cosiddetto microclima permetta una forte competizione tra le piante o meno, poco importa. Ciò che conta è abbassare le rese e aumentare il numero di piante per ettaro. Il pacchetto d’importazione prevede ovviamente la massiccia adozione di vitigni cosiddetti internazionali, ovvero varietà di uva capaci di adattarsi plasticamente a pressoché tutte le condizioni pedoclimatiche della penisola (e delle isole), facili da coltivare, omogeneizzate nel materiale viticolo (grazie alla famosa “selezione clonale”), con il cabernet sauvignon e lo chardonnay a fare da capofila.
Vengono spiantati centinaia di ettari di vecchie vigne, e – ciò che è peggio – di vigne che seguono una tradizione consolidata, ma non corrispondenti ai nuovi criteri della modernità: spariscono intere aree vitate che ospitano varietà a bacca bianca, e pure varietà a bacca rossa ritenute non qualitativamente adeguate. Produttori – considerati ancora oggi illustrissimi dall’intero popolo del vino – sbancano colline, eradicano disinvoltamente vitigni storici, ne mettono a dimora (magari a rittochino, fregandosene della consuetudine locale e facendo qua e là franare parti del campo) altri “migliorativi”, forzano i consorzi per far ammettere cabernet e compagnia cantante nei disciplinari di tipologie lontane anni luce dal modello stilistico bordoleseggiante che comincia in questi anni il suo dominio imperiale.
Parallelamente si diffonde per i rossi, insieme alla figura centrale dell’enologo consulente (presto “enologo star”, “enologo globetrotter”), la ricerca della “maturità fenolica”. Non si vendemmia più basandosi sul semplice grado alcolico potenziale delle uve o assaggiando banalmente gli acini – che scherziamo? –, ma aspettando che la maturazione dei polifenoli sia completa. Che poi le uve, una volta raggiunto il magico punto di maturità tannica, siano spesso svuotate di freschezza e sviluppino un grado alcolico potenziale molto alto, è un dettaglio.
In cantina, infine, la modernità dispiega tutto il suo potenziale tecnologico in termini di manipolazione del materiale vegetale di base. La chimica e i nuovi macchinari enologici forniscono decine di sostanze e di processi per curare o meglio pilotare ogni singolo snodo della vinificazione: si possono modificare pressoché tutti i parametri del mosto, del vino finito, del suo affinamento. Il vino diviene una sorta di plastilina, di materiale elastico, che può essere allungato, accorciato, deformato, modellato a proprio piacimento.
Potrei aggiungere vari altri elementi critici, ma sarebbe manicheo non annotare che questa fase di ristrutturazione – disinvolta, come minimo, e caotica in molte terre d’Italia – abbia portato anche obiettivi miglioramenti qualitativi nella media della produzione nazionale: più attenzione alla maturità e alla sanità delle uve, più pulizia nei diversi snodi della vinificazione, una significativa riduzione del numero di vini difettosi. Nella media, appunto. Avendo come portato pratico, e prima ancora teorico, un generale appiattimento delle differenze, delle peculiarità, dell’originalità del mosaico di vigne italiche “pre-rinascimentali”.
Se questo è vero, e per me lo è in misura significativa, la domanda centrale risulta: nel bilancio tra ciò che è stato buttato a mare e ciò che è stato innovato, il bevitore può essere felice? o ha perso più di quanto abbia guadagnato?
Non occorre scomodare i Padri della Patria vinicola e i loro sacri testi per avere già un’immagine decisamente non coincidente con la vulgata “Deserto dei Tartari/Rinascimento”.
Già che ci siamo però scomodiamoli i padri, su.
Paolo Monelli è buon testimone di un Italia enoica illustre e variegata, sia in un’era geologica antecedente a questa trattazione (anni Trenta e Quaranta), sia nelle pagine di O.P. ossia il vero bevitore, che è un libro del 1963. A pagina 97 si legge:
“Non è mio proposito pubblicare un elenco anche solo parziale dei vini d’Italia, che sono davvero innumerevoli. Centoventi ne annovera l’inglese Charles G. Bode nel suo accurato libro Wines of Italy (Peter Owen, London, 1956), libro nato da buona esperienza e da un grande affetto. (…); oltre seicento sono esaminati da Felice Cùnsolo nel Dizionario del gourmet (1961); settecentotre ne descrive Luigi Veronelli nel suo Vini d’Italia (Canesi, 1961)”
Di queste centinaia di vini molti risultano oggi rarissimi, dispersi o irreperibili. Come piccolo assaggio di nomi evocativi: Clastidio, Epomeo di Porto d’Ischia, Terzigno, Torregiulia, Vernaccia di Solarussa.
Molto più articolata l’archeologia dei nomi citati nelle diverse uscite de I Vini d’Italia di Luigi Veronelli. Nell’edizione del 1964, tra decine di altri, si leggono: Albanello di Siracusa, Alto Sele, Arcola Bianco, Attafi, Barengo, Biancale, Borraccio, Brendola, Campochiesa, Caramino, Castelbracciano, Castrense, Cesnola, Chiaretto del Viverone, Colatamburro, Dorato di Sorso, Fogarina, Griantino, Guncinà, Limassina, Marinasco, Morasca, Naccarella, Orgiano, Pannarano, Parasani, Passolato, Piematone, Roccasusella, Sambiase, Schiablin, Serprina, Terreforti, Torbolino, Tremezzino, Ussolaro, Vecchienna, Vèrice, Vigliano, Zucco.
Si dirà: saranno stati poco più che delle curiosità folkloristiche locali; vinelli senza pretese, quisquilie, pinzillacchere. A giudicare dai toni dell’autore, avrei molti dubbi in proposito. Soltanto sul misterioso Attafi, per fare un singolo esempio, Veronelli arriva a dichiarare: “tre eccellenti vini prodotti in comune di Bianco: l’Attafi rosso, dalle uve alicante, guardavalle, cornicchiola, nerello e mantonaco (…), l’Attafi Greco, dall’uva greco, un bel passito aromatico (…); ed infine, un poco meno alcoolico, un altro passito, l’Attafi Mantonaco, dall’uva mantonaco, di colore giallo dorato.”
Eccellenti. Niente di meno.
E vogliamo a questo punto non ricordare, sia pure al volo, Mario Soldati, terzo nome della trinità dei Padri Fondatori? Il suo iconico Vino al vino (prima parte del 1969) è un inno alla diversità del vino italiano, e insieme il primo grido d’allarme per gli iniziali, inquietanti segnali di omologazione già avvertibili in quel momento.
Lo scettico si ostinerà a dire: occhio che i sacri testi, nella loro autorevolezza indubitabile, sono solo testimoni di carta. Vero. Ma abbiamo ancora dei testimoni liquidi. Delle bottiglie venerabili che si ostinano, Anno Domini 2022, a non defungere.
Tre, cinque, dieci, venti, cinquanta indizi fanno dunque una prova. Se si bevono le poche bottiglie rimaste in vita di vendemmie pre/1985 – le bottiglie “giuste”, è ovvio – si ricostruisce un quadro sensoriale significativamente diverso rispetto a quello spacciato dalla storiografia dominante. E quindi una realtà fattuale significativamente diversa.
Mi piacerebbe essere creduto sulla parola, anche perché fin qui il contabattute di Word mi dichiara un verboso numero di 9.000 e rotti. Né ovviamente servirebbe che elencassi una lunga teoria di etichette e di relative note di assaggio.
Ma insomma, così, tanto per gradire. Molti vini di denominazioni a tutt’oggi famose risultano all’assaggio più ariosi, più longilinei, più complessi aromaticamente di molte loro controparti attuali.
Al netto degli effetti del cambiamento climatico, paiono proprio diversi l’idea, il modello stesso di vino.
Un Chianti Villa Antinori 1975, bevuto da un formato magnum, risulta ancora tonico, succoso, aggraziato nell’esposizione aromatica, privo di forzature nell’estrazione, gentile nel tocco alcolico (12,5 gradi dichiarati). Un Brunello di Montalcino Argiano della stessa annata è altrettanto slanciato e fresco, sebbene più scuro negli accenti olfattivi. Un Barbaresco Borgogno 1952 si concede poco all’olfatto ma al palato è un ricamo delicato e tenace. Un Barolo Cerequio Marengo Marenda (quasi certamente 1982: etichetta poco leggibile) ha grande energia motrice, tannini vivi, bella struttura, ma il tutto declinato in bello stile, sciolto, di effetto naturale: un vino quasi fatto in ossequio alla “sprezzatura” del Castiglione e della Camerata de’ Bardi.
E non si pensi che questo valga soltanto per le Doc e Docg illustri, quelle rinomate anche all’estero. Vale, eccome, pure per le tipologie “minori”, meno celebrate. Un Sizzano 1967 di Francesco Fontana ha configurazione inevitabilmente autunnale negli aromi, ma un sapore ancora vitale, limpido, vibrante. Uno Spanna 1955 Castello di Montalbano è ancora bello vivo, ritmato, ben piantato sulle sue fondamenta tanniche. Un Gattinara Nervi 1961 è invece più gracile e accartocciato su se stesso, ma mostra ancora qualche lampo di vita nelle diafane note di lampone e frutti canditi.
E perché, al sud? Un Castel del Monte 1961 Rivera – antenato de Il Falcone – ha corpo, bilanciamento delle parti, tannini sodi e insospettabile persistenza finale, il tutto senza “freni” nel sapore. E via via, coinvolgendo anche bianchi – sì, proprio: bianchi – e vini dolci.
Infine faccio appena lampeggiare la ieratica presenza dei capolavori, che do per ovvi e che da soli basterebbero a revocare in forse la retorica del Rinascimento: i vini di Mascarello, Cappellano, Conterno, Borgogno, Giacosa, Maga, Soldera, Valentini, e via via.
Quale evidenza emerge allora da questa serie di osservazioni sparse? Per me la verità si colloca in un punto dove non si condannano aprioristicamente i progressi compiuti dalla modernità (1985/2005, per fissare dei paletti convenzionali; anche se di sicuro già da alcuni anni prima etc etc etc), né si esaltano acriticamente i vini del periodo precedente.
Pensare che tutti i vini – o la grande maggioranza – prodotti dal secondo dopoguerra fino al 1985 fossero un omaggio all’autenticità, all’espressività, alla fedeltà alla terra, sarebbe un’idealizzazione. Pensare che tutti i vini – o la grande maggioranza – prodotti dal 1985 alla metà degli anni Dieci venissero da scorciatoie senza scrupoli in vigna e da tecniche invasive, deformanti, omogeneizzanti in cantina, sarebbe una forzatura ideologica.
Ma questo punto in cui si colloca la verità non si trova a metà strada. Non decreta un pari e patta. Nel mio personale bilancio, in quello degli altri non so, alla domanda centrale di esordio, tra ciò che è stato buttato a mare e ciò che è stato innovato, il bevitore può essere felice, o ha perso più di quanto abbia guadagnato? rispondo: forse abbiamo perso più di quanto abbiamo guadagnato.
Forse. Per fortuna stiamo recuperando, mi sembra. Ma questo è un altro periodo storico, che potremmo definire post-rinascimentale.